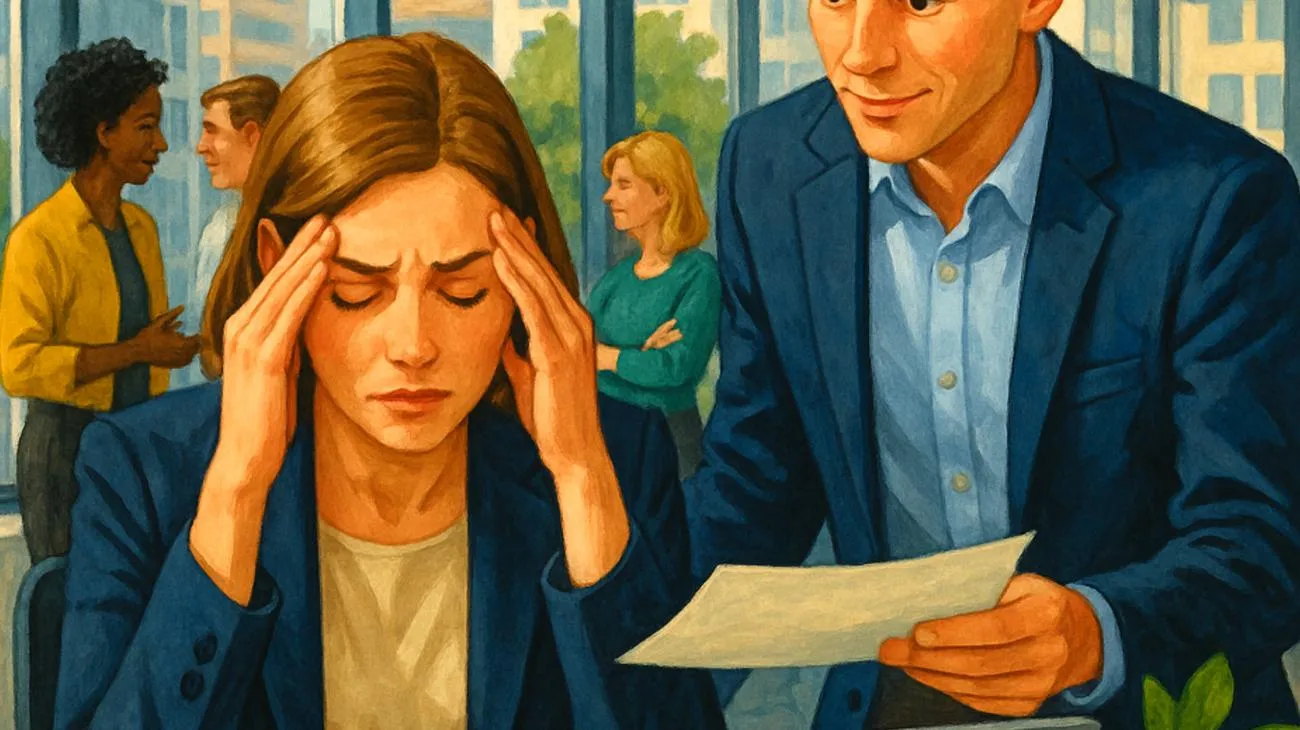Quella volta che il tuo cervello ti ha convinto di essere un truffatore (spoiler: non lo sei)
Alzi la mano chi non ha mai pensato “Madonna, se scoprissero quanto sono scarso mi licenzierebbero all’istante” dopo aver ricevuto un complimento sul lavoro. O chi non ha mai attribuito una promozione a “pura fortuna” invece che alle proprie competenze. Se ti stai riconoscendo, benvenuto nel club più affollato del mondo: quello della sindrome dell’impostore.
Non è una di quelle cose trendy inventate dai social media. È un fenomeno psicologico serio, studiato da decenni, che trasforma anche i professionisti più brillanti in detective privati impegnati a smascherare… se stessi. E la cosa più assurda? Spesso colpisce proprio le persone più competenti in circolazione.
La storia di come due psicologhe hanno dato un nome al nostro peggior nemico interno
Era il 1978 quando Pauline Clance e Suzanne Imes decisero di mettere nero su bianco quello che molte persone di successo sussurravano sottovoce: “Non me lo merito davvero”. Le due psicologhe americane coniarono il termine “sindrome dell’impostore” dopo aver osservato donne professionalmente realizzate che si sentivano delle fraudolente nonostante curriculum da far invidia.
All’inizio si pensava fosse un “problema femminile”, ma col tempo si è scoperto che questa vocina del cavolo non fa distinzioni. Colpisce uomini, donne, giovani, meno giovani, CEO di multinazionali e stagisti al primo giorno. È democratica nel senso peggiore del termine.
Il meccanismo è tanto semplice quanto devastante: quando le cose vanno bene, è merito della fortuna, del tempismo o dell’aiuto degli altri. Quando vanno male, ecco la prova definitiva che “lo sapevo di essere un disastro”. È come avere un sistema operativo programmato male che interpreta ogni dato in modo distorto.
I travestimenti della sindrome: quando l’impostore si nasconde in bella vista
La sindrome dell’impostore è maestra nel mimetizzarsi. Non arriva con una targhetta scritta “Ciao, sono qui per rovinarti la giornata”. Si traveste da comportamenti che dall’esterno possono sembrare normali o addirittura encomiabili.
Il primo travestimento è quello del perfezionista seriale. Non quello sano che ti fa dare il meglio, ma quello tossico che ti fa riscrivere una email venti volte perché “se non è perfetta, capiranno che sono un incompetente”. Chi soffre di sindrome dell’impostore spesso ragiona così: un errore, anche minuscolo, farà crollare tutto il castello di carte.
Poi c’è il “deflettore di complimenti”. Quando qualcuno riconosce il tuo lavoro, parte automaticamente la modalità ping-pong: “Ma no, non è merito mio”, “Ho avuto solo fortuna”, “Chiunque altro avrebbe fatto meglio”. È come se il cervello avesse installato un antivirus che identifica ogni feedback positivo come spam.
Un altro classico è l’auto-sabotatore preventivo. Rimandare progetti importanti, non candidarsi per posizioni perfette per il proprio profilo, evitare occasioni di visibilità. La logica malata è: “Se non ci provo sul serio, quando fallirò potrò sempre dire che non ho dato tutto”.
Il terrore del “prima o poi mi beccano”
Ma forse il segnale più tipico è quella sensazione di vivere come un fuggiasco. Chi soffre di sindrome dell’impostore passa le giornate con la paura che qualcuno prima o poi si svegli e pensi: “Ma questo qui che ci fa? Non sa nemmeno di cosa sta parlando!”.
Questa paranoia porta a comportamenti da preparazione olimpica: studiare ossessivamente prima di ogni riunione, prepararsi risposte a domande che probabilmente nessuno farà mai, evitare di dire la propria opinione per paura di dire una castroneria epica.
Il paradosso crudele: più sei bravo, più ti senti un truffatore
Ecco la parte che fa più rabbia: la sindrome dell’impostore spesso colpisce proprio le persone più competenti. È quello che gli psicologi chiamano un bias di attribuzione particolarmente cattivo. Più ottieni risultati, più aumenta la sensazione di aver preso tutti in giro.
Gli esperti hanno identificato alcuni pattern tipici: concentrarsi esclusivamente sui propri errori (anche quelli microscopici), sottovalutare sistematicamente le proprie capacità, e vedere solo gli aspetti negativi in ogni situazione. È come avere degli occhiali da sole permanenti che filtrano tutto il positivo.
Il risultato è un sistema di valutazione interno completamente sballato: i successi finiscono nel cestino degli “incidenti fortunati”, mentre ogni piccolo intoppo diventa la conferma definitiva che “lo sapevo di essere una schiappa”.
La ruota del criceto che non si ferma mai
La sindrome dell’impostore è bravissima a creare circoli viziosi. La paura di essere smascherati porta a lavorare il doppio per compensare le presunte mancanze. Ma invece di aumentare la fiducia, questi risultati extra vengono interpretati come “ecco, sono riuscito a fregarli di nuovo”.
Questo meccanismo infernale può portare a conseguenze serie: burnout da superlavoro, ansia cronica, problemi nelle relazioni personali e, paradossalmente, la rinuncia a opportunità professionali fantastiche per paura di non essere all’altezza.
Chi finisce più facilmente nella trappola dell’impostore?
Anche se tecnicamente può capitare a chiunque, ci sono alcuni fattori che sembrano aumentare le probabilità di finire in questo club poco esclusivo. Chi cresce in famiglie con aspettative altissime o in ambienti ipercompetitivi spesso sviluppa questo tipo di insicurezze.
Anche il posto di lavoro gioca un ruolo importante. Ambienti dove sbagliare è considerato un crimine capitale, dove il feedback è raro come la pioggia nel deserto, o dove nessuno spiega mai come funzionano le valutazioni, sono terreni fertilissimi per questo tipo di dubbi.
I momenti di transizione sono particolarmente rischiosi: il passaggio dall’università al lavoro, una promozione importante, un cambio di settore, o l’ingresso in un team dove tutti sembrano sapere cose che tu non conosci.
Quando l’ambiente di lavoro diventa complice
Alcuni contesti lavorativi sono praticamente progettati per far fiorire la sindrome dell’impostore. Pensa a quegli uffici dove regnano la competizione spietata, la mancanza di trasparenza sui criteri di valutazione, o quella cultura tossica del “se non sai questa cosa ovvia, sei fuori”.
Anche la mancanza di diversità può alimentare questi sentimenti. Quando sei l’unica donna in un team di uomini, l’unico giovane tra veterani, o l’unico che viene da un background diverso, è facile sentirsi come se non si appartenesse davvero a quel mondo.
Come distinguere la sindrome dell’impostore dall’essere semplicemente umili
Attenzione a non confondere la sindrome dell’impostore con l’umiltà genuina o la normale consapevolezza dei propri limiti. La differenza sta nell’intensità e nella persistenza di questi dubbi, oltre che nell’impatto che hanno sulla tua vita quotidiana.
Una persona umile riconosce i propri meriti pur restando aperta a imparare e migliorarsi. Chi soffre di sindrome dell’impostore, invece, nega sistematicamente ogni merito e vive in uno stato di ansia permanente riguardo alle proprie competenze.
È importante sapere che la sindrome dell’impostore non è riconosciuta come disturbo clinico ufficiale nel DSM, il manuale dei disturbi mentali. Questo non la rende meno reale o meno fastidiosa per chi la vive, ma significa che è più un fenomeno psicologico che una patologia vera e propria.
Le mille facce dell’impostore interno
Non esiste una versione standard della sindrome dell’impostore. È come un virus che si adatta all’ospite. Alcune persone la manifestano diventando perfezioniste paralizzate, altre evitando sistematicamente ogni sfida. C’è chi diventa un maniaco del lavoro nel tentativo di compensare le presunte carenze, e chi invece si svaluta talmente tanto da non provarci nemmeno.
Alcuni sviluppano la “sindrome dell’esperto”: sentono di dover sapere tutto prima di aprire bocca. Altri vivono la “sindrome del genio naturale”: se qualcosa richiede sforzo, allora significa che non sono tagliati per quella cosa.
Riconoscere quale versione dell’impostore interno hai in casa è fondamentale per iniziare a gestire la situazione in modo costruttivo.
I numeri che fanno riflettere
Secondo una revisione sistematica pubblicata sul Journal of General Internal Medicine, tra il 9% e l’82% delle persone sperimenta sensazioni riconducibili alla sindrome dell’impostore almeno una volta nella vita. La variabilità dipende dal tipo di studio e dalla popolazione analizzata, ma il messaggio è chiaro: non sei solo in questa battaglia.
Ricerche più recenti suggeriscono che il fenomeno sia particolarmente diffuso in alcuni settori, come la tecnologia, la medicina, il mondo accademico e le professioni creative. Non a caso, ambiti dove l’apprendimento continuo è necessario e dove è facile confrontarsi costantemente con persone che sembrano saperne sempre più di te.
L’effetto sorprendente del parlarne apertamente
Una delle scoperte più interessanti degli ultimi anni riguarda l’effetto liberatorio del parlare apertamente di questo tema. Sempre più aziende stanno creando spazi di discussione dove i dipendenti possono condividere le proprie insicurezze senza essere giudicati.
Il risultato? Quando le persone si rendono conto che anche il collega super sicuro di sé o il capo che sembra avere sempre tutte le risposte hanno gli stessi dubbi, l’effetto è incredibilmente rassicurante.
Verso una nuova consapevolezza: il primo passo per liberarsi
La buona notizia è che la sindrome dell’impostore, una volta riconosciuta, può essere gestita efficacemente. Il primo passo, spesso il più difficile, è ammettere che quella vocina critica nella tua testa potrebbe non essere il giudice imparziale e competente che pensavi.
La psicoeducazione, cioè semplicemente capire che questo fenomeno esiste e ha un nome, è già un passo avanti enorme. Molte persone provano un sollievo incredibile quando scoprono che i loro dubbi hanno una spiegazione scientifica e che non sono gli unici a provarli.
Un altro aspetto fondamentale è iniziare a mettere in discussione i propri pensieri automatici. Quando il cervello parte con “È stata solo fortuna”, prova a chiederti: “Ma davvero? O forse c’entra anche il fatto che ho studiato, mi sono preparato e ho messo impegno?”
- Tieni un diario dei successi e scrivi le azioni concrete che hai fatto per raggiungerli
- Metti in discussione i pensieri negativi automatici
- Celebra i tuoi risultati invece di minimizzarli
- Cerca feedback costruttivi da persone di cui ti fidi
Il potere inaspettato di circondarsi delle persone giuste
Non sottovalutare l’importanza dell’ambiente che ti circonda. Cerca di stare vicino a persone che ti danno feedback costruttivi e onesti, che celebrano i tuoi successi senza sminuirli, e che ti aiutano a vedere le tue qualità quando tu non riesci a vederle.
Al contrario, cerca di limitare il tempo passato con chi alimenta i tuoi dubbi, con i critici seriali o con chi ha sempre qualcosa da ridire su tutto quello che fai.
Se ti sei riconosciuto in questo articolo, ricorda una cosa importante: il fatto stesso che ti stai ponendo queste domande, che stai riflettendo sulla tua competenza e che vuoi migliorarti, è probabilmente la dimostrazione più chiara che sei esattamente il tipo di persona coscienziosa e capace che merita il successo che ha ottenuto.
La prossima volta che l’impostore interno inizierà il suo solito monologo, prova a rispondere con un sorriso: “Grazie per il promemoria, ma oggi scelgo di fidarmi dei fatti invece che delle paure”. Non sarà facile all’inizio, ma con un po’ di pratica potresti scoprire che quella vocina fastidiosa inizia a parlare sempre più piano.
Indice dei contenuti